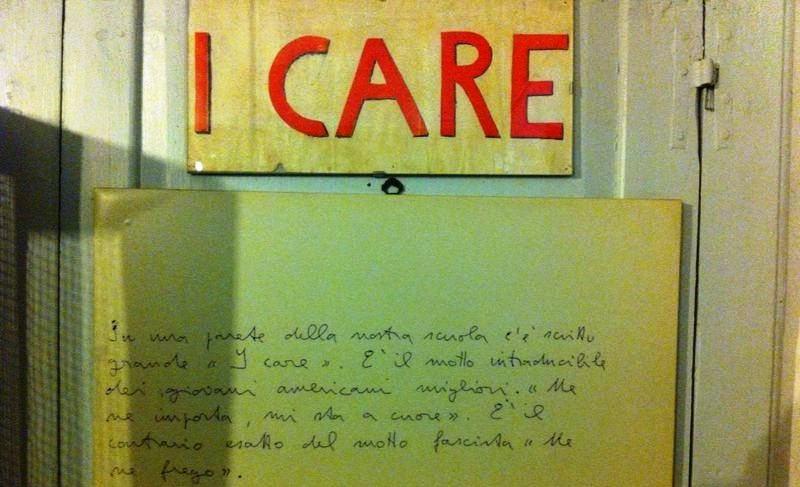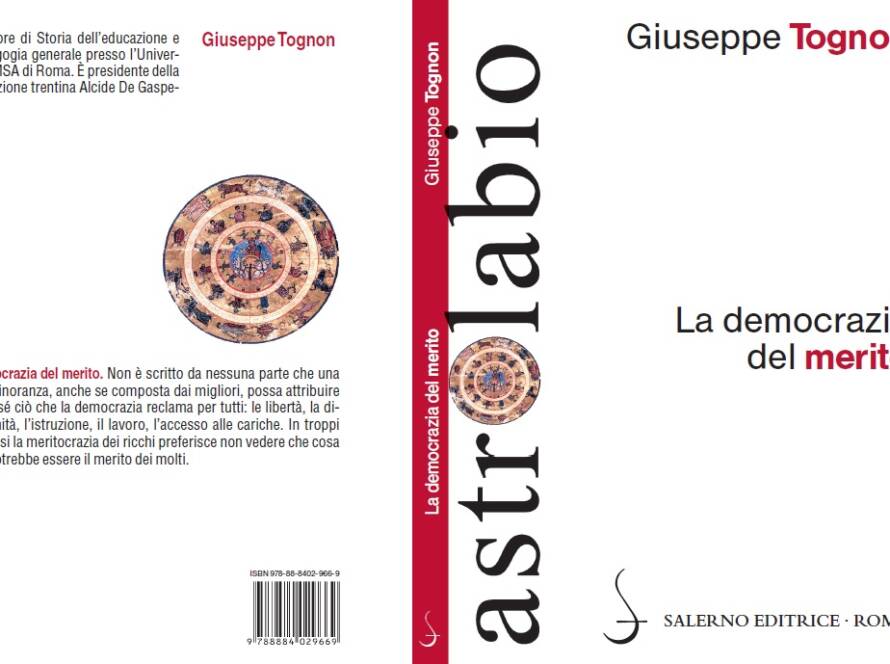Far amare la scuola
La sfida di far amare la scuola. Quella domanda di ascolto che incalza noi insegnanti
 Che cosa sa un insegnante dei suoi studenti? Che cosa conosce del loro vissuto quotidiano, dei loro problemi, delle loro passioni, aspettative, speranze? Spesso, poco, troppo poco. Perché tu sei uno, e loro sono tanti. Il docente è un individuo che instaura una relazione con un gruppo (la classe) più che con altri individui. Eppure una classe è data dalla somma di diversi individui. E sappiamo quanto ciascun ragazzo, soprattutto in età adolescenziale, abbia bisogno di essere riconosciuto e valorizzato nella sua singolarità e unicità. Certo non aiuta il fatto di avere classi con 30 alunni (quelle che con brutta espressione giornalistica vengono chiamate “classi pollaio”): ma purtroppo il risparmio, nonostante certi roboanti proclami dei nostri governanti, è ancora il criterio principale, quando non addirittura quello esclusivo, a cui vengono improntate le politiche scolastiche nel nostro Paese.
Che cosa sa un insegnante dei suoi studenti? Che cosa conosce del loro vissuto quotidiano, dei loro problemi, delle loro passioni, aspettative, speranze? Spesso, poco, troppo poco. Perché tu sei uno, e loro sono tanti. Il docente è un individuo che instaura una relazione con un gruppo (la classe) più che con altri individui. Eppure una classe è data dalla somma di diversi individui. E sappiamo quanto ciascun ragazzo, soprattutto in età adolescenziale, abbia bisogno di essere riconosciuto e valorizzato nella sua singolarità e unicità. Certo non aiuta il fatto di avere classi con 30 alunni (quelle che con brutta espressione giornalistica vengono chiamate “classi pollaio”): ma purtroppo il risparmio, nonostante certi roboanti proclami dei nostri governanti, è ancora il criterio principale, quando non addirittura quello esclusivo, a cui vengono improntate le politiche scolastiche nel nostro Paese.
Nonostante le difficoltà oggettive, però, sento che conoscere il più possibile la realtà di quei ragazzi che ogni giorno incontro in aula è una parte fondamentale del mio lavoro. Anzi, forse ne è addirittura la premessa. Ecco perché ogni volta che mi viene assegnata una nuova classe, il primo tema che assegno è di tipo personale. È un peccato che la scrittura personale e “creativa” sia un genere piuttosto marginalizzato nella scuola di oggi, che, soprattutto alle superiori, predilige forme più tecniche (l’analisi del testo, il testo argomentativo, il tema storico o d’attualità…). Invece quando i giovani vengono invitati a parlare di sé, lo fanno volentieri, scrivono in modo mediamente più corretto del solito (perché quando tratti un argomento che possiedi, anche la forma ne guadagna) e l’insegnante si annoia meno a correggere.
Dunque, avendo quest’anno tre nuove classi (una prima, una seconda e una terza liceo), ho assegnato questo compito: «Traccia brevemente un tuo autoritratto». Leggendo temi di questo tipo, negli ultimi anni ho notato un certo cambiamento. Mi sembra che sempre più i ragazzi tendano a parlare di aspetti anche molto privati e intimi, cosa che fino a qualche anno fa accadeva meno. Diversi di loro scrivono, per esempio, della separazione dei genitori, che raccontano sempre in termini negativi come un trauma che hanno subito, un fulmine a ciel sereno che a un certo punto si è abbattuto sulla loro vita, anche se poi, fortunatamente, la capacità di resilienza ha avuto la meglio. C’è chi racconta di lutti recenti, spesso la scomparsa di un nonno o di una nonna a cui si era particolarmente legati. Qualcuno esprime il disagio per un difetto fisico che viene percepito come un ostacolo insormontabile all’accettazione da parte degli altri (ma prima ancora da parte di sé). Una ragazza di origini straniere parla di certe battute a sfondo razzista che l’hanno ferita: e qui dovrò trovare il modo di approfondire con lei l’argomento. Alcuni, poi, parlano della scuola come di un ambiente dal quale non si sentono veramente accolti: spunto per un serio esame di coscienza da parte di noi docenti. Scrive un ragazzo: «Anche se quasi sempre ho avuto buoni voti, detesto la scuola, perché è un luogo dove non mi sento umano, mi sento un prodotto che viene testato per essere perfetto, come se i voti che mi vengono dati non fossero altro che recensioni o risultati di test di qualità». È una critica forte a quel mito (od ossessione) della misurabilità che pervade l’attuale sistema di istruzione. Un ragazzo di prima liceo, invece, ha concluso il suo testo così: «In questo breve tema di quattro colonne spero di aver fatto capire chi sono, con i miei pregi e difetti. Se invece rimango ancora uno sconosciuto, sentitevi liberi di ignorare la mia esistenza, a me va bene comunque, anche se mi dispiacerebbe».
La mia sensazione è che gli adolescenti abbiano un grandissimo bisogno di essere ascoltati, e che lo chiedano esplicitamente. A noi insegnanti spetta l’enorme responsabilità di essere interlocutori credibili. Non stanchiamoci mai di guardarli negli occhi e di chiederci chi sono. Ma, soprattutto, di “esserci”: per loro, per ognuno di loro.
Fonte: Avvenire del 23 ottobre 2019